Come una puledrina
La troia
Si dimena
Gioca il gioco
Del non volere
Quando poi
Per i fianchi la fermi,
Ancora un poco
Muovendo il culetto
Prova a scalciare
Infine
Presa
E stremata,
Non può
Che lasciarsi fare.
E comincia
A miagolare.

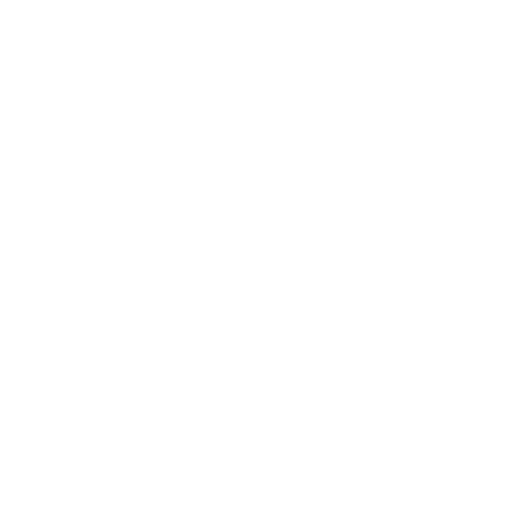
L’acqua che tocchi del torrente è l’ultima che sta andando, la prima di quella che viene. Così è il tempo presente, come il torrente. Cade dall’alto del colle, e fragile come un pargolo che vede la luce del mondo, svenendo si tuffa sulla via della vita.
Poi sbuffa i primi vagiti senza saper cosa sarà tutto quel blu lontano a valle laggiù, senza saper che nel mare si va, a scivolare, ancor di più, precipitare … ecco si, precipitare come un canto al cielo innalzato, come un mistero che già vuol esser salvato, come uno iato, un grido d’aiuto … una domanda quel cader nella vita inatteso, quel trovarsi corpo … mistero sospeso …
L’acqua che tocchi del torrente è l’ultima che sta andando, la prima di quella che viene. Così è il tempo presente, come il torrente.
D’un tratto potente nell’ergersi tra valli, rocce, frasche, dirupi, ed erbe fresche, così che trovando forza serpeggia sinuoso tra le dita degli alberi … e ancor più scendendo accarezza i pesci d’argento, e come contento abbevera il verde selvatico che lo circonda … e poi la terra feconda, fino all’ultima spruzzo di onda, fino a tremare prima di gettarsi, ecco si, nel mondo del mare, diciamolo con una parola, fino a lasciarsi andare, alla vita, all’amore.
(Tratto dal prologo dello spettacolo “Per i tuoi occhi chiari”, storia di Aldo Gastaldi, “Bisagno”)
Chi sei tu,
Nascosta nel mio cuore,
Dimmi chi sei, Anima mia?
Il profumo soffice del fiore,
O quella barchetta laggiù
Nel mezzo del mare?
Dimmi chi sei, Anima mia?
Io ti figuro
Come campanella che trilla
Nell’oscuro,
Come fontanella,
Acqua che sviene
Nei palmi concavi,
Tra le celesti vene.
Dimmi chi sei, Anima mia?
Tu, cerbiatta,
Abiti il mio cuore
Come un’eterna promessa
Come un illusione.
Dimmi dunque, chi sei?
Dimmi,
Dove nascondi il filo d’oro
Che cuce le stelle nel cielo?
Mio padre si chiamava Giorgio, Giorgio Giandrini. Nato nell’aprile del 41 a Mortara in provincia di Pavia si è presto diplomato all’Unasas, scuola acconciatori per signore. Pur arrivando dalla provincia e da una famiglia povera, già a venticinque anni era proprietario di due negozi; uno a Santa Margherita Ligure per la stagione estiva e l’altro a Milano, in Piazza Cinque Giornate, vicino al Coin. Nel suo lavoro era bravo, bravissimo.
Un talento meraviglioso nel “giocare con i capelli”
Amava toccarli, riordinarli, colorarli, e soprattutto … tagliarli.
Il lunedì, quando il negozio era chiuso, andava in giro per l’Europa a fare dimostrazioni nei teatri accompagnato dalla sua troupe e da una fila di simpatiche modelle dai capelli morbidi e lunghissimi. Talvolta le sue “esibizioni” erano accompagnate da Pippo Baudo, Mike Bongiorno, e ricordo anche, giovanissimo, Beppe Grillo … tutti personaggi che conducevano la serata presentando le acconciature.
Ha vinto numerosi concorsi italiani ed europei, ed è stato campione del mondo “singolo” e “a squadre” rispettivamente per una e due volte. Dopo aver venduto i negozi, ha speso gli ultimi anni della sua professione insegnando con affetto ai giovani per i quali si offriva volentieri.
La sua più grande passione era “andare in campagna”; il mercoledì non c’era mai in negozio perché andava a pescare insieme allo “zio Sergio”. Pescava ovunque: in mari, fiumi, laghi e persino nei fossi. Riusciva a prendere le tinche e le carpe nascoste nei fossi con le mani.
Gli piaceva mangiare e bere bene. Amava la cucina di pesce, soprattutto quello alla griglia, ma anche il panino con il salame in qualche bettola di legno.
Lo ricordo come una persona fine, sempre distinto e misurato nelle conversazioni.
Portava nel cuore un personale, tremendo dolore, che conosco, e del quale non ha mai parlato.
Durante la sua malattia mi ha insegnato l’eleganza.
Era un collezionista di errori.
Alcuni gravi.
Mi ha voluto,
Per come ha potuto
E per quanto ha saputo,
Bene.
Molto bene.
E io gli sono grato
Profondamente grato
Di tutto.
Iva compresa.
Svolazza nel cielo dal 2003, accade di vederlo seduto sulla luna con la sua canna a pescar le stelle, più spesso si diverte a pettinare le piume degli angeli.
Faccio l’artista
Scrivo e metto in scena.
Mi incontro nella profondità del Silenzio.
Bazzico il basso come l’alto.
I pesci nuotano, e l’aquila vola.
Il rosario è una preghiera bellissima.
Il rosario sorride della new age
Come il saggio dell’approvazione.
Mi interessa l’Amore.
Sopra tutto.
Cerco uomini generosi
Uomini potenti,
Che hanno fame di senso
Di direzione,
Che vogliono spendersi
A cuore alto.
Non ho bisogno di recintare l’istinto.
Quando occorre nutro il lupo.
E sento il profumo della femmina che ha scavalcato il lamento.
Amo i suoi colori
Le forme della carne
La baldanza
Nella tana
Nera e morbida,
E tutto quel mondo da pastrugnare
Da prendere
Penetrare.
Aborro il gruppo come il latte della mamma.
Agli ami occorre girare le spalle.
Non riconosco padroni.
Scrivo per frequentare l’amore del Padre.
Del quale sono,
A testa alta
E in perenne morte,
Anche un fiero cavaliere.
Cercate la bellezza e innamoratevi di tutto.
Innamoratevi degli alberi,
Come dei rami così delle rose.
Di tutte le spine innamoratevi!
Innamoratevi di quello che accade.
E’ tutto, è sempre, un miracolo.
Innamoratevi, altrimenti vince la pianura.
E invece no, cercate le vette!
Tuffatevi nudi negli abissi del dolore
E gridate che tutto è domanda.
Innamoratevi delle stelle silenziose.
Del vento che suona il violino,
E di tutti gli uccellini fringuenti innamoratevi!
Dei capelli biondi e lucenti
Delle schiene ossute innamoratevi.
Delle spalle scoperte e bianche
Innamoratevi dei seni freschi e ridenti.
Innamoratevi oltre la paura
Che tutto nasce nella bellezza.
Tutto ingravida la Bellezza.
La notte la vince solo l’aurora,
La illumina senza eliminarla.
L’ alba non perfora la notte
Come fanno i nostri mille inutili lampi al neon.
L’ alba inonda la notte,
Piano,
La imbeve di sé.
Avete mai visto?
Quando stridono i primi uccellini,
E si rincorrono i primi gridi dagli alberi,
E passa il primissimo tram?
Dapprima la rende più bella.
L’ alba esalta la bellezza della notte,
La illumina dentro.
Poi,
Morbida la schiarisce.
Come quando si tolgono le foglie
Da una soglia di casa,
Come quando si toglie la sabbia
Da sopra una conchiglia,
Come quando si spostano i capelli
Da sopra un bel viso.
E allora, la vita riappare.
E il naufragar m’è dolce
In Questo mare.
(Tratto dallo spettacolo: “La vita è una notte, viaggio intorno a Giacomo Leopardi” di Davide Giandrini e Davide Rondoni).
Che io vibri
Di fuoco e di grazia.
Di forza e tenerezza.
E più ancora,
Di instancabile
Potenza e carità.
Spendendomi tutto per Te.
Amatissimo
Silenzio.
Talvolta a tarda sera accade,
Di percorrere in bicicletta
I campi,
Tra le sterrate
Di paesi addormentati.
E mentre,
I pensieri profondano
Nell’ amore
Loro,
Piccole e fragili,
Ad intermittenza
Danzano
Tra le labbra di settembre.
Bisbigliando una domanda.
Piove.
Dell’acqua cade dall’alto.
Come fosse una cosa normale.
Occorrono i nervi della menzogna. Ma si può. Strappare dalla radice. Il cuore. Vederlo pulsare rosso sul palmo. Stringere a pugno. E voltando la nuca scagliarlo per terra. Si può. Guardare il cuore lì per terra ai nostri piedi. Prendere una manciata di polvere e lasciarla cadere a cascata. Sul cuore. Poi un’altra manciata di polvere. E lasciarla cadere a cascata. Sul cuore. Atto austero. Preciso. Manciata di polvere. Che cade. A cascata. Sul cuore. Fino a coprire tutto. Il cuore.
Ora governa l’aridità. I profumi non indicano strade. Squalificato il corpo come il gusto dall’ingoio. Ridotta la pacca a stretta di mano e il Fallo a pisello. Nella prigione della testa fino alla fine della carne. Tessere ragnatele. Pensieri in cerchio si rincorrono. Futuro a ripetere. Criceto autistico. Inferno dove digrignare vien detto riso. Plastica. Plexiglass. Polistirolo. All’orizzonte l’orizzontale. L’ipnosi della misura è il mantra dei matematici. L’atto solo servo del calcolo.
Allegria gente. Uno più uno fa sempre tre. Lo sa anche un bambino, dai.
Senza farla troppo lunga. Il Miracolo è una cosa che sta lì.
Serve spogliarsi. Tuffarsi. Nelle Acque Dolci.
Lunga è la via per il Fiume. Come lunga è quella per la Docilità. Occorre tutto per poter perdere. Volere tutto. Per finalmente perdere. Occorre la volontà di Ulisse e di un certosino la pazienza. Occorre la lacrima del dolore e il grido ancor di più. Vomitare sangue concorre a stare nel rapporto come concorre la bestemmia. E poi, profonda come il cielo deve essere la speranza. Come il desiderio dev’essere la speranza. Infinita.
Lunga è la via per il Fiume. La preghiera è sorella silenziosa. La preghiera partecipa alla muta del serpente. Non siamo cipolle. Abbiamo il cuore! E’ cosa grande. E’ cosa di tenerezza infinita! E’ cosa d’amore il cuore. Rispettarne il ritmo. Tutto il tempo che vuole il tempo. Tutto lo spazio che vuole lo spazio. Non meno e mai di più. Lunga è la via per il Fiume.
E’ il lavoro della vita. Togliere per essere. Il lavoro della vita. E il cuore si conforma al cuore nel tempo.
La grazia dell’abbandono arriverà.
Cosa devo fare? Stare.
Cioè? Stare.
Ho capito, ma cosa devo fare? Stare.
Vuoi dire che non devo fare niente?
Voglio dire che occorre stare, ecco tutto.
Dall’inattività l’azione come dal silenzio l’esplosione.
Dal caos l’ordine.
Guarda che accade nella stalla.
Guarda che nasce dal Vuoto.
L’Amore.
(Prefazione a “Il sentiero delle acque dolci”, autobiografia di un’individuazione maschile. DI Paolo Mombelli. Casa Editrice Serra Tarantola)
…Ragazzo,
Devi essere certo come un capitano e
Morbido come fumo d’incenso.
Inebriala con gli occhi negli occhi
E guardale per un attimo le labbra bellissime.
Poi torna ai suoi occhi calmo
E avvolgendola,
Incantala.
Incantala,
Che nell’essere morbido
Non puoi darle tregua.
Se lei ancheggia scostandosi un poco
Sorridile, e prendila.
Stringendola a te.
Annusale un poco il collo che avrà profumato
E sussurrale qualcosa dietro all’orecchio
“Ciao bella fighetta!”
Lasciale il tempo che occorre
Per diventare ancora più morbida
E abbracciandola tutta
Piantale i denti nel collo!
Sii fermo.
E tirandole i capelli all’indietro
Tieni ancora i denti nel collo.
E’ tua.
E sarà contenta di esserlo.
Quando arriva il momento,
Mai prima, mai dopo,
Spogliala lento ammirandola tutta.
Dille quanto è bella.
Quanto ti piace.
“Come sei bella amore … ma come sei bella!
Sei bellissima amore!”
Se la ami spalanca il cuore e diglielo
“Ti amo … ti amo amore mio, ti amo tanto!”
Poi, osserva con attenzione
La sorpresa di quel corpo nudo.
E controlla la bramosia.
Lasciati commuovere da quel corpo.
Lascia che quella bellezza ti tocchi nel profondo.
Lascia che ti tocchi il cuore.
Poi, adorala.
Adorala tutta.
Come fosse una preghiera silenziosa
Adorala,
Senza dimenticare di ringraziare il Cielo
Per tutta questa bellezza.
Non dimenticarlo mai.
Sii sempre tenero, sempre certo.
Potente, sii potente.
E ogni tanto – spesso gioca!
Si… gioca!
Gioca allegro!
Allegro come i bambini giocano.
Ridendo libero!
Poi, bacia le sue guance, le palpebre
Baciala tutta, tutta.
Baciala, leccandola a bocca socchiusa e delicatamente.
Baciala e annusala.
Ovunque.
Fallo, con tutta la tua dedizione.
Fallo, gustando i meravigliosi sapori del suo corpo,
Odorando tutti i suoi profumi di femmina.
Baciala e annusala ovunque.
Ovunque.
Le ascelle, i fianchi, i polsi celesti, la fighetta, l’interno delle braccia, i polpacci, le caviglie, le costole, le guance, le ossa tutte, una per una, il sedere, l’interno delle cosce, dietro il collo, la schiena …
E mentre lo fai, ogni tanto torna al viso e guardala negli occhi … sorridile.
Non tralasciare un millimetro.
Fallo con la massima cura.
Con totale dedizione.
Fallo come fosse una preghiera.
(…)
Ragazzo,
Chi non sa pregare “davvero”
Non sa scopare.
Davvero.
Profumata di rami scompigliati
E’ un trionfo di energia
La Selvatica!
Lei,
Che volta le spalle
Al calcolo come al lamento,
Non offre riflessi allo specchio.
Ma sorride allegra della troppa vanità.
Il suo compito è l’offerta.
Dell’ anima come del corpo.
Che meraviglia la Selvatica!
Segreta e nascosta
Come filo d’erba
In un campo maturo di grano,
Contempla
Le regole silenziose
Della natura.
Bella la Selvatica!
Che danza per i suoni,
E si eccita per i profumi,
Delizia quando freme per il tocco,
E assapora tutto il gusto.
Da sdraiarcisi di fianco
Occhi al cielo
A guardar le stelle
Per la notte intera.
Bella la Selvatica!
Oltre il dogma e la confezione,
Dopo il diritto e il piagnisteo,
C’è la Selvatica!
Che ama la carne e il piacere
E contempla il Silenzio
Con gratitudine.
Donna,
I Maschi ti cercano Selvatica.
Fuori dai modi del mondo,
Ma nel piacere profondo
Desiderano
Lodare Dio con te.
E’ un piano terreno
Che guarda il mare,
Genova
Una morbida troia
Da infilzare.
E’ vento – petrolio
Tutto metallo,
Gabbiano nero
Nell’ acqua in stallo.
E’ una palpebra offesa
Un nido di cosce,
Il getto maschio
Dal quale
Si nasce.
E’ una Rosa monastica
Sul tappeto del mare,
Un piano terreno
Da benedire.
Nel bosco
Da sotto le spighe con occhi sgranati
Le zampe al balzo son pronte.
La tigre
A striscie d’oro
Ti ha scelto
Cerbiatta prediletta.
Sul sentiero di ghiaia
Morbide e tonde
Le tue forme di femmina
L’ hanno invitata.
Ondeggiale ancora cerbiattina
Profumane i campi della tua voglia
Che un tuono arriva da dietro
Il maschio ti ha preso
I denti sul collo
Le unghie nel dorso
Il Fallo tra il pelo.
Godi cerbiatta
Godi
Tra una nuvole di polvere.
Con gli abbracci di lana
E i baci labbra uva
Ho cura di te
Accarezzando il tuo cuore
Come il vento
Alza la piuma
Nell’aria ballerina.
Con l’inchiostro
Che soffia la vita
Sul morto bianco foglio,
E cantando
Raccontando
Dai legni del palco.
Ho cura di te
Amando i più poveri
Che mi somigliano
Come uno specchio
E sento fratelli.
Quando duro entro
Nel cuscino del tuo
Pelo nero
E tu svieni godendo
Ho cura di te.
Ineffabile Anima mia.
Come una puledrina
La troia
Si dimena
Gioca il gioco
Del non volere
Quando poi
Per i fianchi la fermi,
Ancora un poco
Muovendo il culetto
Prova a scalciare
Infine
Presa
E stremata,
Non può
Che lasciarsi fare.
E comincia
A miagolare.
Che se una donna,
Almeno una notte
Non li indossa guardandoti
Come Oriana Fallaci
Guarderebbe
Non c’è guerra.
Ed Eros sviene,
Senza Sangue.
Urge
La Naturale inimicizia
Tra i generi.
Che nella battaglia
Chiama amore,
Sesso,
E figliolanza.
Così nel dolore,
Quanto nel piacere.
Nel novanta avevo diciannove anni, ero magro come un hippy con i capelli lunghi alle spalle la prima volta che insieme a una mora fidanzata, andai a Tempio Pausania per incontrare Fabrizio De André. Occorreva arrivare nella zona industriale della piccola città, lasciarla alle proprie spalle, e cominciare a percorrere, se ricordo bene, via Bachisio: una sterrata tra il verde selvatico e qualche vacca. Dopo due tre chilometri un cartello di legno indicava “Agnata”, la tenuta dove De André insieme alla bellissima Dori viveva, facendo il contadino.
Ne ero e ne sono innamorato. Di Fabrizio. Mi commuove molto di lui.
L’eleganza dei modi, la voce profetica, la palpebra offesa, le parole che arrivano da un luogo lontano e profondo, forse dall’acqua o dalla terra, di certo da qualcosa che ha a che fare con il Silenzio. Tornai qualche anno dopo, e dopo ancora, e poi lo incontrai in giro mille volte per concerti.
L’undici gennaio del novantanove per l’ultimo saluto, partii da solo alle prime luci dell’alba con una vecchia fiat malconcia, così d’arrivare tra i primi nella Basilica di Santa Maria Assunta, sulla Collina di Carignano, a Genova. Perché gli volevo bene, gli ero grato.
Di Fabrizio De André si conosce molto, si sa che si dichiarava anarchico, che amava la natura e l’astrologia, lo dicono tutti. Si sa delle scorribande giovanili tra prostitute e transessuali con l’amico Paolo Villaggio. Si ricordano le date del suo rapimento. Si sa anche, che ha bevuto molto whisky, e tanti ricordano addirittura la marca delle sigarette che fumava. E ovviamente tutti sanno, che ha cantato di puttane e magnacci, di delinquenti e assassini, di omosessuali discriminati, e di emarginazione. Si sa, appunto, lo dicono tutti.
C’è però un’altra persona, la sola di cui Fabrizio abbia cantato per tutta la vita.
Una persona che l’ha disturbato come una scheggia sotto il tallone, che l’ha accompagnato come un abbraccio morbido. Non ha potuto fare un passo, un disco, senza ricordarsi di quella persona. Gli ha offerto decine di canzoni. Gli ha regalato centinaia di versi. Alla vicenda umana di questa persona, gli ha dedicato un disco intero e, io credo, gran parte del suo cuore. Fino all’ultima canzone, fino a quella “goccia di splendore consegnata alla morte”.
Gesù.
È soprattutto dal rapporto con questa profonda spiritualità, tutta immelmata di carne, che nasceva la meravigliosa arte di Fabrizio De Andrè.
(Buio. Si sente da lontano “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla per una trentina di secondi. Si alza lenta una sola luce al centro palco. Entra l’attrice: ha un vestito bianco di lino con delle rose rosse qua e là. E’ a piedi nudi e tieni in mano dei sandali in canapa. Si posiziona in centro scena.
C’è una sedia di fianco all’attrice. Sfuma la musica).
Io sono la donna del faro. Faccio il terzo turno. Da mezzanotte alle otto del mattino. Da quattordici anni al faro del porto. Navi che vanno pescatori che tornano e io qui. Faccio il mio mestiere. Il più bello del mondo. Osservo il mare. Lo osservo nei suoi movimenti sensuali, nella sua potenza. Nel suo mistero. Lo osservo tutte le notti. Da quattordici anni. E con la fantasia mi ci tuffo dentro. Nel buio della notte e delle onde, e nuoto a scendere. Fino ad arrivare al fondo. E lì, nel fondo, ho scoperto cosa si nasconde.
In quelle culle d’onda. Si nascondono i misteri dei millenni. La storia del mondo.
Nel fondo del mondo blu c’è tutto. C’è la comunità dei morti. Più vasta di quelli che campano. E quelli che campano sono di più di quelli che vivono. E quelli che vivono poi sono di più di quelli che gustano. E quelli che gustano sono di più di quelli che cercano. E quelli che cercano poi sono di più di quelli che amano. Che sono pochi. Pochissimi. E si confondono. Tra il marasma del fare. E nessuno li riconosce che non hanno lustrini e nemmeno pajette… che non hanno voce alta e fosforescenze. Non hanno palchi, pedane, fari, voti, altari, applausi. I pochi, pochissimi, che amano si occupano d’amare.Tutto qui. Niente di più nulla di meno.
Il mare è l’altro mondo, quello fondo. Blu. Tra di noi.
Ci sono le ombre degli uomini. I segreti come le gioie. E poi le speranze tutte ci sono. E le cose spostate ci sono. Le grida, le risa, i muscoli degli uomini forti, e i cuori che hanno desiderato tanto. E poi tutti gli occhi che hanno pianto. Tutti questi occhi che hanno pianto ci sono. Come le labbra che hanno baciato. E le volontà, ci sono le volontà che hanno realizzato. E i coraggi, ci sono i coraggi che hanno cambiato. La tristezza in responsabilità.
E ancora ci sono i santi. E le puttane. Nel fondo del mondo blu. I santi belli. E le puttane belle. I santi che parlano agli uccellini e gli uccellini che rispondono ai santi. Che è una cosa dell’altro mondo ma è vera. Gli uccellini che parlano dai rami. E i santi che hanno cuore per sentirli. Per capirli. E allora dialogano tra di loro che sembrano facciano l’amore i santi con gli uccellini.
Come capita anche alle puttane. Con gli uccellini dico.
(Sfuma la la luce fino all’ombra. Ritorna “Com’è profondo il mare” in sottofondo. L’attrice si siede incrociando le gambe nude. Sfuma al silenzio la musica e l’attrice riprende a raccontare).
E’ l’odore del sale che rimane attaccato alle mie labbra. Quello che piace al mio uomo al mattino quando torno a casa. Lui si procura da vivere scrivendo storie. Così… al mattino quando torno mentre prepara il caffè dice sempre: “Ho due proposte farti!” “Dimmi amore mio” “O mi racconti cos’hai visto nel fondo del mare questa notte, oppure ti prendo e facciamo l’amore sull’amaca?!” (Rivolgendosi al pubblico) Che sono due belle proposte, ma a volte, dico, dopo una notte trascorsa sveglia da sola al faro non è che… insomma sia così vispa da voler farmi girare e rigirare come una gallina sull’amaca….e dunque, ogni tanto, ma solo ogni tanto, rispondo “Stanotte osservando il mare ho scoperto delle cose nuove”. “Cos’hai scoperto?” dice lui.
Che ci sono i dolori preziosi come gemme e le tenerezze splendenti. Tutto appoggiati sul fondo. E le preghiere ci sono. E poi le domande come le risposte. E le persone che si sono inginocchiate davanti alla croce e quelle che hanno danzato a piedi scalzi sull’erba verde. E i cavaliere cha hanno vinto il drago. E quelli che hanno vinto il re. E anche quelli che hanno vinto il sacerdote. Giganti appoggiati nel fondo del mare. E poi c’è la leggiadria dei capelli che hanno corso al vento. E l’allegrezza dei seni che ciondolavano. E lo sperma sulle chiappe sorridenti. C’è tutto nel fondo del mondo blu.
(Si sente “You and the nght and the music” nella versione di Chet Baker in sottofondo, l’attrice si alza e raggiunge il proscenio).
Ci sono i figli mai arrivati. E quelli andati. Che non si può morire bambini! Che non è giusto morire bambini! Non è proprio giusto morire da bambini! E bisogna dirlo al mare come al cielo e gridarlo che non si può morire bambini!
(…)
C’è tutto nel fondo del mondo blu. Ci sono i pompini fatti come una preghiera segreta. Gli uomini e le donne che si sono toccati come si accarezza il volto di Gesù, e quelli che si sono baciati come asciugando una lacrima e anche quelli che si guardano come dirsi grazie. Con tutta la speranza che grida nel loro cuore come un vento alto. Che trabocca come un non trovare le parole.
(…)
(Il testo intero è in vendita. Per informazioni davide.giandrini@fastwebnet.it)
Abitavo in Via Pasquale Sottocorno ed Enzo Jannacci aveva lo studio in Via Mameli. Sono due strade che si incrociano nella zona quasi centro di Milano.
Alla fine degli anni settanta avevo sette otto anni, e ricordo che domandavo a mia madre di uscire intorno alle due, perché a quell’ora, andando ai giardini di Corso Indipendenza, c’erano più probabilità di incontrare “quel signore con la Lambretta che canta”.
E infatti, spesso capitava l’occasione, e quando Jannacci si fermava al tabacchi sotto casa subito lo raggiungevo.
Era, per me bambino, uno diverso dagli altri, difficile spiegare. Aveva tempi e modi diversi del dire. Tempi e modi diversi del muovere il corpo. Uno strano simpatico, Jannacci. Gli ridevano gli occhi.
Nei primi anni ottanta invece, giocavo a calcio in una società che si chiamava Enotria in zona Crescenzago, e nel tardo pomeriggio appena finiti gli alleamenti Jannacci arrivava a prendere suo figlio Paolo. Si fermava ogni tanto con me e gli altri ragazzi a mangiare in quel baretto di legno. Panino con il salame. E vino. Rosso.
Poi, anni dopo, quelli di Aspettando Godot con Gaber, il sabato mattina andavo a correre in Viale Romagna e accadeva di incontrarlo mentre caricava il pianoforte in macchina per andare a lavorare. Io correndo gli gridavo “Enzo, son sciopà!!”, e lui, “fermati allora!!”.
E poi ancora nei primi anni novanta, siamo in “zona Guarda la fotografia” una sera d’inverno, con Milano tutta pioggia, lo vedo fermo in Viale Gran Sasso dentro ad una Fiat 127 amaranto … con la scatola di Tavernello. Da solo.
Oppure notte tarda, all’edicola di Porta Venezia a comperare il proibito.
E ancora a Chiaravalle per il funerale di Gaber in Chiesa con la moglie, aveva le spalle basse e guardava sempre la croce, attento. Nella stessa mia panca: che la pace sia con te e con il tuo Spirito.
Nel 2004 al Primo Festival Gaber a Viareggio, è stato bello lavorare sullo stesso palco mezz’ora prima di lui. Bello guardare il suo modo assolutamente libero, di provare, di prepararsi. Poco prima di salire in palco con la band che sta già suonando davanti a tremila persone … d’ un tratto sparisce … non si trova più … Paolo lo cerca … e lui, spuntando da dietro una pianta “ … arrivo, ‘speta un mument, non si può neanche andare in bagno!!!”
Negli ultimi anni molte volte a salutarlo al “Granga”, Ristorante Gran Galeone in via Fiamma. Una sera entro, e lo vedo con un occhio viola e il tovagliolone al collo come i bambini seduto con davanti un’aragosta intera.
Come sta Signor Enzo? “Come sto!? Stò con un’occhio viola!?”.
Un’altra volta gli dico che voglio scrivere un pezzo su Gesù e che mi sarebbe piaciuto parlarne con lui, risponde :“Guardi lasci stare Gesù, ho detto una frase sul Nazareno un paio d’anni fa e ci sono quelli di comunione e liberazione che continuano a chiamarmi che non mi mollano più, un rumpiment de ball che non ne posso più … no no, di Gesù non si parla”. Poi mi lascia il suo telefono e mi dice di chiamarlo quando voglio.
L’ultima occasione estate 2012. Sono in Viale Romagna in bicicletta, lo vedo che cammina pieno di dolore e accompagnato da una signora, intuisco, e mi fermo. Gli dico appassionato, Signor Enzo io volevo ringraziarla per quello che ha scritto, grazie per il modo in cui ha fatto il suo mestiere, grazie, per noi è stato molto importante ascoltare le sue canzoni, e osservare il suo modo. Grazie.
E lui “Ma non esagerare dai”.
Sono passati più di cinque anni dalla sua morte.
Mi domandavo: cosa ricorderò, oltre a tutto il suo lavoro? Cosa rimane in me di questi incontri?
Può apparire strano, ed è anche difficile spiegarlo, ma in questi incontri, io ho sempre avvertito Jannacci come un uomo profondamente spirituale. Un uomo in rapporto con la sua parte più profonda. Una parte si, stralunata e inspiegabile agli occhi di chi brama la norma. Però vera. Era lui. E ci dev’essere stato un momento nel quale, portandone poi sempre il peso, Jannacci ha scelto di abbracciare quei suoi modi e quei suoi tempi. “Strani”.
Ho sempre stimato tutta la sua Opera principalmente per questo.
E trovo che il suo lavoro nascesse sempre, o quasi, da questo abbracciare se stesso. Questo, a me sembra, gli ha consentito di essere originale. Libero. Senza posticci ideologici. Senza risi accattivanti o consumistici.
A differenza di come poteva apparire l’ho sempre avvertito attento. Presente, mentre ti era davanti e gli stavi parlando.
Interessato all’altro.
Di Jannacci ricorderò senz’altro la figura di un uomo che ha saputo tuffarsi nel fiume senza provare a nuotare. Si è lasciato fare. Pur di essere sé stesso.
Qualche tempo fa in via Solferino incontro Ornella Vanoni.
Femmina come femmina è una tigre.
Indossa calzoni e maglietta in lino bianco
E un foulard bordeaux al collo.
Trucco?
Perfetto.
Ci slautiamo e sul marciapiede stretto
Cominciamo a conversare: teatro, musica…
La guardo come si guarda una Dea
Che ha profumato il tessuto morbido del cuore.
Come fosse una Dea
Che ha nascosto un diamante
Tra le gambe.
Alla fine dico “posso darti un bacio?!”
Non risponde a parole, ma…
Allarga la braccia e sporge la bocca.
Le bacio, gentile, le labbra.
Ciao.
Ciao Ornella.
(… e che io ci farei l’amore anche domani …
ma dice che “io” sono troppo vecchio … azz!!)
Non li risparmiare i tuoi abbracci, mai.
Non li risparmiare i tuoi baci, mai.
Non lo risparmiare il tuo amore, mai.
Che l’amore non gioca con il calcolo.
Gira le spalle
L’amore al calcolo.
Il risparmio è catastrofe.
La paura è catastrofe.
L’acqua sul fuoco
E’ la catastrofe.
La catastrofe
E’ il roditore che rimane.
A pensare
E rimestare
A ragionare
E soppesare
A bilanciare
E calcolare
A rimuovere.
Gli impauriti tutto guadagno e
Le impaurite lamentose
Sono la catastrofe.
Ma davvero hai ancora voglia di poppare latte?
Non li risparmiare i tuoi abbracci, mai.
Non li risparmiare i tuoi baci, mai.
Non lo risparmiare il tuo amore, mai.
Altrimenti la partita
Si perde
Tristi edulcorati
Nello specchio prigione.
Intorno al 2010 andai a vedere Paolo Villaggio al Teatro Filodrammatici di Milano. La sala era gremita. Si apre il sipario e sulla scena completamente vuota c’è lui, che vestito con una specie di larghissimo pigiama bordeaux rimane in silenzio per almeno 40 secondi (tempo infinito ad inizio spettacolo).
Rimane in silenzio, e guarda il pubblico stando seduto a gambe larghe su una sedia di legno, e con i testicoli penzolanti in chiara evidenza.Poi comincia un monologo “a braccio” sulla decadenza alla quale porta l’età, su i “coglioni penzolanti”, e sulla caccia alle lucciole vicino al mare in Liguria. E’ un racconto pieno di fantasia, di visioni, di immagini. Pieno della vita di un uomo che l’ha vissuta, la vita.
Alla fine dello spettacolo lo incontro fuori dal camerino e ci fermiamo qualche minuto a conversare. Quella sera fredda d’inverno io indossavo un tabarro blu mare fatto su misura, un tabarro che amo molto e che lo incuriosì: cominciò a farmi una serie di domande … non si poteva parlare di altro: dov’è l’ha comprato? quanto l’ha pagato? ma è di lana? e se piove? ma il colore l’ha scelto lei?
Io rispondevo davanti a quella figura con i capelli bianchissimi e con la barba alla Mosè. Lui portava una giacca di pelle nera e dei jeans; ricordo che stava in piedi fermo sulle due gambe senza muoversi di un passo, e puntando gli occhi “severi” su di me. L’impressione era quella di essere davanti ad un uomo potente. Potente della sua intelligenza. Alla fine mi lasciò il suo indirizzo chiedendomi, gentilissimo, di inviargli notizie sul tabarrificio, cosa che naturalmente feci.
Villaggio ha creato una maschera altissima. Un clown inarrivabile. Villaggio è stato come Buster Keaton, come Chaplin, come Totò, Stanlio e Olio. Ha giocato a fare l’Ombra di molti italiani, a rappresentare “l’uomo medio” nella sua banalità, nella sua nascosta aggressività; in fondo ha raccontato sempre della disperata tristezza di quell’uomo.
Per questo alcuni non l’hanno mai sopportato. Perché non sopportavano di guardarsi allo specchio attraverso Fantozzi.
Ma questo è il dono del comico vero. Mostrare la povertà.
Grazie dunque a Paolo Villaggio, è stato una meraviglia!
Ho sfilato il mantello d’oro
Dalla mia schiena
Per posarlo sulle tue vecchie spalle.
E, nudo di tutto,
Ti ho adorato
Come un Dio si adora.
Innalzandoti
Oltre l’altare.
Quando poi, vestito di me
Hai chiuso, dittatore,
Ogni serratura
E claudicante
Sei andato
Con il petto gonfio del potere
Il male
Mi ha strizzato
Le viscere
Fino alla magrezza.
Infine
Son tornato a riprendere
Il mio mantello d’oro
E d’un tratto
Sei imploso, incenerendo
Adesso,
Ti vedo senza nebbia
Ricordandomi di te quando voglio ricordarmene.
Pavone,
Ho scelto di non farti del male
Ma non passare con la ruota
Dalle mie parti
Ti sbrano.
(Ad un narcisista mascherato di selva)
Come una puledrina
La troia
Si dimena
Gioca il gioco
Del non volere
Quando poi
Per i fianchi la fermi,
Ancora un poco
Muovendo il culetto
Prova a scalciare
Infine
Presa
E stremata,
Non può
Che lasciarsi fare.
E comincia
A miagolare.